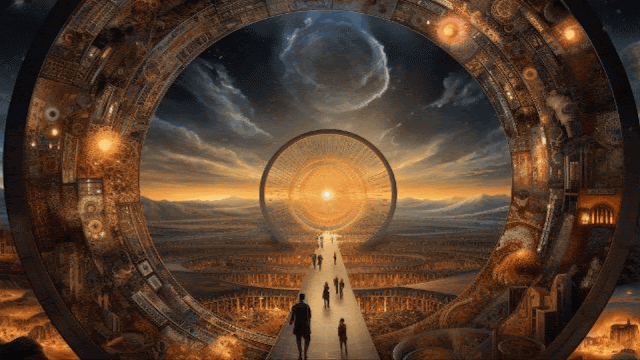Questo è uno studio del linguaggio del prodotto animato giapponese e, soprattutto, delle modalità attraverso cui il prodotto animato nipponico comunica con lo spettatore. Non solo giapponese. La decisione di adottare un approccio per l’appunto di tipo pragmatico nasce da tre constatazioni strettamente collegate. In primo luogo, nell’animazione giapponese il rapporto comunicativo con lo spettatore, uno spettatore ben preciso, risulta pressoché fondamentale. In secondo luogo, è solo in base a questo rapporto, la cui natura viene svelata nel corso dell’analisi, che la produzione animata nipponica si definisce e si differenzia dalle altre produzioni animate. In terzo e ultimo luogo, l’animazione giapponese finisce più o meno inconsapevolmente col sottoporre a processo di metaforizzazione l’età del proprio spettatore di riferimento: l’adolescente.
Prefazione di Alberto Boschi
La dignità artistica dell’animazione nipponica è ormai pienamente ammessa sia nell’ambito della critica cinematografica che in quello degli studi accademici. A tale riconoscimento tardivo ha contribuito negli ultimi decenni la qualità indiscutibile dei lungometraggi cinematografici firmati da registi prestigiosi quali Mamoru Oshii o Hayao Miyazaki. Più lento e accidentato sembra essere invece il processo di rivalutazione del disegno animato seriale, su cui pesano ancora, almeno in parte, gli sciocchi pregiudizi maturati nei tempi ormai lontani in cui le serie robotiche hanno invaso per la prima volta i nostri schermi televisivi, durante i quali l’aggettivo “giapponese” era divenuto sinonimo di un’animazione a bassissimo costo, standardizzata tanto nella forma che nei contenuti e capace di produrre danni irreparabili nelle giovani menti dei suoi sprovveduti spettatori. Proprio l’animazione giapponese di serie, che sotto vari aspetti e in misura variabile ha condizionato e formato in tutto il mondo l’immaginario giovanile, è al centro del libro di Marco Teti, il quale presenta senz’altro rispetto alla letteratura saggistica dedicata precedentemente all’argomento almeno tre novità di un certo rilievo. Innanzitutto, l’autore si occupa per la prima volta nello specifico del rapporto che tali prodotti sono in grado di stabilire con il proprio pubblico, esaminando le operazioni linguistiche e i procedimenti enunciativi capaci di fare nascere e consolidare suddetta relazione. E sufficiente in effetti dare un’occhiata, anche superficiale, agli episodi di cui è composta una qualsiasi serie proveniente dal Giappone per rendersi conto della fondatezza della tesi enunciata nel libro, ovvero che il rapporto di tipo comunicativo instaurato con lo spettatore definisce lo stile e soprattutto “l’identità” del cosiddetto anime, il disegno animato nipponico.
2009
ll disegno animato di serie prodotto nell'arcipelago giapponese ha conquistato negli ultimi decenni un ruolo di assoluta centralità nel campo della cultura di massa. All'origine del fenomeno si collocano fattori di ordine diverso. Uno dei più importanti di essi è rappresentato dalla creazione, da parte dei realizzatori degli anime (neologismo coniato in Giappone, ottenuto contraendo il termine inglese animation, per indicare le opere animate nipponiche), di un linguaggio diretto e immediato in grado di fare presa su di un pubblico costituito in prevalenza da bambini e adolescenti. Il saggio prende inoltre in esame la poetica, l'impianto strutturale e il progetto estetico che emergono dalle serie animate giapponesi.